| |
Un paio di costellazioni visibili in Dicembre
A Sud: Orione - latino Orion, abbreviazione Ori
La costellazione di Orione (Fig. 1) appartiene al cielo australe e si trova proprio a cavallo dell’equatore celeste. Alle nostre latitudini, inizia a vedersi quando la Terra si avvia a completare il suo percorso annuale attorno al Sole, ossia negli ultimi mesi dell’anno.
 fig.2 fig.2 |
Orione si dispiega nel cielo per 594 gradi quadrati, collocandosi per estensione al ventiseiesimo posto fra le 88 costellazioni che adornano la volta celeste. Si tratta di una costellazione di dimensioni medie che si distingue per la semplicità con cui si lascia individuare; vi sono infatti quattro luminose stelle disposte a trapezio che ne racchiudono altre tre nel centro, brillanti e assai vicine fra loro. Osservata al telescopio, Orione si rivela estremamente interessante e suggestiva perché possiede una concentrazione e una varietà di oggetti celesti davvero singolare: supergiganti blu e rosse, stelle doppie e multiple, ammassi stellari e nebulose, queste ultime peraltro famosissime. In un’unica costellazione è così possibile seguire quasi l’intero ciclo di vita di una stella, dato che sono appunto disponibili all’osservazione vari rappresentanti celesti delle diverse fasi di evoluzione di una stella. |
|
|
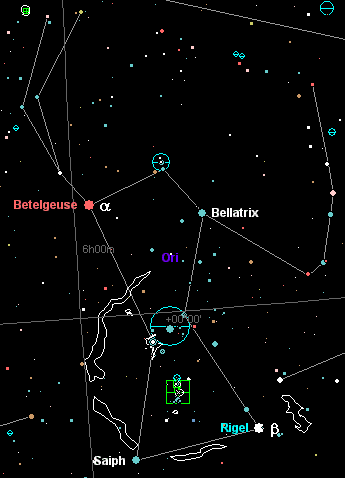 fig.1 fig.1 |
Zodiaco: Ariete
latino Aries, abbreviazione Ari
 fig.3 fig.3 |
Prima costellazione dello zodiaco, l’Ariete occupa 441 gradi quadrati di cielo (Fig. 18). E’ la 39a costellazione in ordine di grandezza fra le 88 totali; tuttavia le stelle che ne tracciano il disegno sono sostanzialmente 5 e sono discretamente vicine fra loro, così che la maggior parte della sua area è in realtà impegnata da stelle che non hanno a che fare con la sua sagoma (Fig. 18).
Purtroppo non è una costellazione estremamente brillante essendo la maggior parte dei suoi astri di 5a magnitudine, cioè quasi al limite della percezione umana. E’ pertanto indispensabile un cielo molto buio per poterla osservare in modo completo senza limitarsi alle uniche due stelle di 2a magnitudine che possiede. Per rintracciarla nel cielo possono venirci in aiuto le costellazioni con cui confina che sono: a nord Perseo, a nord-ovest il Triangolo, a sud-ovest i Pesci, a sud la Balena e a sud-est il Toro. Al cospetto di un cielo sufficientemente buio, si possono contare fino a 20 stelle, solo 5 delle quali però tracciano la forma che identifica la costellazione.
Riferendoci a queste ultime, la più luminosa è Alpha Arietis con magnitudine apparente 2,00, mentre la più debole è Nu Arietis con 5,43 magnitudini. Le 5 stelle danno un contributo medio alla luminosità di questa parte principale della costellazione pari a 3,83 magnitudine, facendo così rientrare l’Ariete fra le costellazioni quasi di 4a classe.
Se consideriamo invece anche il contributo delle altre 15 stelle, la luminosità media totale della costellazione si abbassa a 4,93 magnitudini; l’Ariete cioè diventa una costellazione vicina alla 5a magnitudine, quasi 3 volte più debole rispetto a prendere in considerazione solo le 5 stelle principali. |
|
Viste le varie considerazioni e statistiche fatte sulla luminosità della costellazione, approfitto per ricordare che cosa sono le magnitudini e come va interpretato il loro valore.
Anticamente, quando l’unico strumento per l’osservazione del cielo era il proprio occhio, le stelle furono suddivise in 6 classi di luminosità, dove la 1a classe identificava le stelle più brillanti e la 6a quelle più deboli. Fu l’astronomo greco Ipparco che nel II secolo a.C. adottò questa nomenclatura e queste 6 classi divennero poi quelle che noi ora chiamiamo magnitudini.
La magnitudine che, come abbiamo visto, è un numero puro, cioè non è seguito da alcuna unità di misura, è legata matematicamente a quella che viene chiamata luminosità di una stella. Quest’ultima invece è una grandezza fisica vera e propria, in quanto ci dice qual è la potenza luminosa della stella per unità di tempo e di superficie. In altre parole, la domanda che si fa è la seguente: in 1 secondo ogni centimetro cubo della stella quanta energia luminosa emette? Senza entrare troppo nei dettagli della definizione, possiamo dire che fondamentalmente ciò che lega la magnitudine e la luminosità è una scala logaritmica. Per intenderci, se m è la magnitudine e l la luminosità, il legame non è di proporzionalità diretta, cioè non è del tipo m = kl, dove k indica un valore costante, ma è del tipo m = k Log l, dove Log è il logaritmo in base 10. La scala logaritmica è dovuta al fatto che la risposta dell’occhio umano allo stimolo visivo è di tipo logaritmico. Perché è importante sapere questo? E’ importante per poter valutare l’entità della differenza in luminosità in relazione alla differenza di magnitudine. Mi spiego meglio. Dire che una stella è di magnitudine 1 e un’altra è di magnitudine 4, non significa che la prima è 4 volte più luminosa. Per il rapporto logaritmico fra magnitudine e luminosità infatti, la prima è ben 16 volte più luminosa della seconda!
Per i più interessati, riporto la formula esatta che lega la magnitudine alla luminosità: m = 2,5 Log l.
Per finire, quando si parla di luminosità di una stella, bisogna specificare a quale luminosità ci si sta riferendo. Vi è infatti una luminosità apparente, che dipende sostanzialmente dalla distanza della stella dalla Terra, ed una luminosità assoluta o vera, che rappresenta invece l’effettiva intensità di luce emessa da essa, cioè dipende dalla potenza del suo “motore interno”.
Una stella infatti ci può apparire più luminosa di un’altra solo perché è più vicina, ma magari si scoprirebbe che, portata alla distanza di quell’altra, essa brillerebbe con la stessa intensità o magari di meno.
Per distinguere la magnitudine apparente da quella assoluta, si sono adottate le scritture “m” per indicare la magnitudine apparente e “M” per indicare quella assoluta. Stessa cosa è stata fatta per la luminosità, la cui scrittura “l” indica la luminosità apparente e “L” quella assoluta.
Sempre per i più interessati, la formula che lega la magnitudine apparente con quella assoluta, mettendo quindi in gioco la distanza, è: M – m = 5 – 5 Log d, dove d è la distanza della stella dalla Terra.
Tornando alla nostra costellazione, l’Ariete non possiede né stelle né oggetti celesti “famosi”, ma si riscatta per così dire dal suo modesto lato scientifico, attraverso un ricco e duplice mito, di cui racconteremo la vicenda iniziale. |
sud: Lepre
latino Lepus, abbreviazione Lep
|
La Lepre è una costellazione invernale che rimane piuttosto bassa sull’orizzonte e quindi è soggetta maggiormente all’assorbimento da parte dell’atmosfera che in questa direzione appare più densa (Fig. 1l). Per questo ai fini osservativi è necessario un cielo terso, oltre che un paesaggio senza ostacoli. La localizzazione è però agevolata grazie al fatto che poco distante si trovano Sirio, la stella più luminosa del cielo, e Rigel, la seconda stella di Orione (Fig. 2l).
Le 8 stelle che disegnano la sagoma della costellazione iniziano ad affiorare sull’orizzonte a inizio novembre per inabissarsi di nuovo al di sotto a partire da metà marzo e scomparire del tutto alla fine del mese. La costellazione dunque è visibile durante i 5 mesi invernali.
La Lepre si estende per 290 gradi quadrati, dimensione che la colloca al 51° posto fra le 88 costellazioni dei due emisferi celesti ed è attorniata a nord da Orione, a ovest dall’Eridano, a sud dalla Colomba e dal Cielo e a est dall’Unicorno.
Le sue stelle principali come abbiamo detto sono 8, la più luminosa delle quali è Alpha Leporis con una magnitudine apparente di 2,58, mentre la più debole è Delta con 3,81 magnitudini apparenti, il che significa che è più di tre volte meno luminosa della Aplha. Mediamente la costellazione risulta di 3,32 magnitudini.
La costellazione della Lepre non ospita oggetti o stelle famosi, tuttavia è possibile trovare l’ammasso globulare catalogato da Messier M79 (Fig. 3l ). Si trova a 41.000 anni luce da noi e per attraversarlo impiegheremmo circa 100 anni viaggiando alla velocità della luce. Rispetto alla quasi totalità degli ammassi globulari che si trovano attorno al centro galattico, M79 ha la particolarità di essere situato al di fuori dell’orbita del Sole, posizione giustificabile solo con un origine non galattica dell’ammasso. Si pensa appartenesse alla galassia irregolare chiamata la Nana del Cane Maggiore, scoperta nel 2003 e a soli 25.000 anni luce di distanza, e che sia migrato nella nostra Via Lattea in seguito a un’interazione, ancora in corso, delle due galassie. |
sud: Colomba
latino Columba abbreviazione Col
|
Con l’inizio di dicembre, appaiono le prime stelle della Colomba (Fig. 5c), una costellazione dell’ultima fascia visibile di cielo boreale oltre la quale comincia l’emisfero australe. La Colomba raggiunge la sua massima altezza sulla volta celeste in gennaio e rimane visibile completamente fino a metà febbraio, dopodiché inizia il suo tramonto che si conclude a metà marzo. Proprio il fatto di essere all’estremo sud fa sì che in pratica sia visibile solo per due mesi e mezzo su un periodo di dodici mesi.
Con i suoi 270 gradi quadrati di estensione è la 54° costellazione dell’intero cielo, dunque è una costellazione di modeste dimensioni. Come vedremo, non possiede stelle particolarmente brillanti che ne evidenzino la posizione, tuttavia per localizzarla ci si può servire delle vicine Orione e Cane Maggiore, l’una per la sua inconfondibile forma, l’altra per essere la dimora della splendente Sirio. A circondare la Colomba vi sono la Lepre a nord, il Cielo a ovest, la Poppa a est e il Cane Maggiore a nord-est (Fig. 6c). La costellazione confinante a sud è a noi preclusa essendo la prima dell’emisfero australe ed è il Pittore. La sagoma della Colomba è tracciata da sei stelle, la più brillante delle quali è Alpha Columbae con 2,64 magnitudini apparenti, mentre la più fioca è Gamma con 4,36, una differenza di magnitudine equivalente a una luminosità quasi cinque volte inferiore alla Alpha. Mediamente è una costellazione di 3,63 magnitudini, dunque poco luminosa, altro elemento che non gioca a favore di una immediata identificazione. |
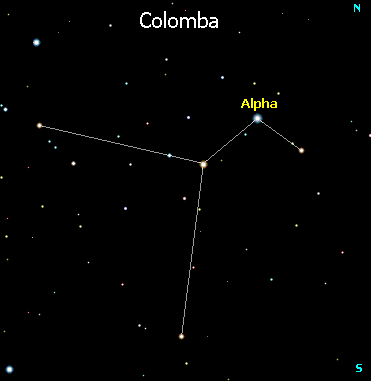 fig.5c fig.5c |
 fig.6c fig.6c |
Stelle famose nelle costellazioni di Dicembre
In Orione
Betelgeuse: il nome deriva dall’arabo Yad al-Jawze significa mano del centrale.
Betelgeuse rientra fra le venti stelle più luminose di tutta la volta celeste.
Il tedesco Johann Bayer, che identificò le stelle basandosi sulla loro luminosità rispetto alle altre della costellazione, chiamò Betelgeuse alpha Orionis. In questo inventario dell’inizio del XVII secolo, la prima lettera dell’alfabeto greco doveva identificare la stella più brillante fra quelle della costellazione, così che la sequenza alfabetica ordinava le stelle per luminosità decrescente. Tuttavia il criterio di Bayer, sebbene fosse il primo di tipo scientifico (fino ad allora infatti alle stelle veniva assegnato un nome legato alla loro posizione in cielo, mentre Bayer le chiamò basandosi per la prima volta su una loro proprietà fisica), presentava facilmente la possibilità di cadere in errore. Egli infatti non sempre azzeccò l’ordine giusto delle luminosità e gli capitò di vedere in Betelgeuse la stella più brillante di Orione, quando invece non era così. Dal momento che il catalogo di Bayer per motivi di tradizione storica non è stato corretto, occorre essere prudenti nella sua lettura, poiché è facile per alcune stelle essere tratti in inganno.
Chi ha già masticato un po’ di astronomia, sa che quando si parla di luminosità di una stella, bisogna specificare a quale luminosità ci si sta riferendo. Vi è infatti una luminosità apparente, che dipende sostanzialmente dalla distanza della stella dalla Terra, ed una luminosità assoluta o vera, che rappresenta invece l’effettiva intensità di luce emessa da essa, cioè dipende dalla potenza del suo “motore interno”, per usare un linguaggio semplice. Una stella infatti ci può apparire più luminosa di un’altra solo perché è più vicina, ma magari si scoprirebbe che, portata alla distanza di quell’altra, essa brillerebbe con la stessa intensità o magari di meno. Per esprimere la luminosità di un corpo celeste, si usa un numero puro chiamato magnitudine e, in analogia con la luminosità, può essere apparente o assoluta.
Quanto detto fino ad ora sulla luminosità di Betelgeuse appartiene alle misurazioni apparenti.
In particolare, la magnitudine apparente di Betelgeuse è circa 0,5.
La sua magnitudine assoluta invece è pari a circa – 5,6 o superiore.
La distanza dal Sole di Betelgeuse è di circa 650 anni luce, ciò significa che se potessimo viaggiare alla velocità della luce, 300.000 km/s, dovremmo viaggiare nello spazio per 650 anni prima di raggiungerla. Alternativamente, significa anche che l’immagine che vediamo oggi di Betelgeuse è quella di 650 anni fa, poiché questo è il tempo necessario ad un raggio della sua luce per giungere sino a noi. Ma un intervallo di tempo di quest’ordine di grandezza è praticamente insignificante nella vita di una stella, o più precisamente nella vita di una stella della cosiddetta Sequenza Principale, e quindi possiamo ragionevolmente supporre che oggi Betelgeuse sia ancora così.
Betelgeuse ci appare di colore rossastro anche ad occhio nudo: siamo infatti al cospetto di una Supergigante Rossa. Queste stelle sono stelle vecchie, che stanno lottando fra la vita e la morte, e di cui noi possiamo osservarne il respiro sottoforma di pulsazioni in luminosità e/o dimensioni. Betelgeuse in particolare scandisce i suoi battiti variando la sua magnitudine apparente da 0,3 a 0,6 in poco più di 5 anni. Una oscillazione piuttosto esigua come questa, unita ad una periodicità non perfetta ma abbastanza costante, la fa rientrare nella classe delle cosiddette variabili semiregolari. E proprio la variabilità della magnitudine può essere la responsabile dell’errore commesso da Bayer quando la classificò come la più luminosa di Orione. Può darsi infatti che egli l’abbia osservata nel momento di maggior splendore e che per questo gli sia apparsa come la alpha Orionis. Situazioni come queste mettono in evidenza i limiti del criterio adottato da Bayer.
Tornando alla descrizione della stella, essendo Betelgeuse una Supergigante rossa, la sua temperatura superficiale si aggira sui 3.000°K. E chi ha dimestichezza con le temperature stellari, che possono superare i 20.000°K, sa che si tratta di una stella molto fredda. E infatti Betelgeuse è una stella che sta morendo. Essa ha esaurito da tempo l’idrogeno presente nel suo nucleo, quell’enorme riserva che l’ha fatta brillare per milioni di anni fra le stelle giovani, ed ora si mantiene in vita bruciando l’elio nel quale si è trasformato l’idrogeno degli inizi. In questa fase finale, per contrastare il collasso gravitazionale a cui è sottoposto il suo nucleo di elio, la stella è costretta a pulsare raggiungendo un diametro pari a circa 500 volte quello del Sole. Per farci un’idea, stiamo parlando di una stella che si estenderebbe quasi fino a Giove! Una superficie di quest’ordine di grandezza implica una luminosità 100.000 volte più alta di quella del Sole. E anche la sua massa non è da meno: è compresa fra le 15 e le 30 masse solari. E’ proprio il caso di dire che è “Supergigante”!
Su Betelgeuse soffia un vento solare fortissimo, così forte che ogni 36 ore la sua superficie perde una massa di gas pari a quella della Luna. Che ne sarà di questa stella così tormentata? Il suo destino è quello di diventare una Supernova, arriverà un giorno in cui esploderà, e l’esplosione sarà così potente che raggiungerà la luminosità dell’intera Galassia! Betelgeuse sarà la Supernova più vicina a noi finora osservata. L’evento è a prima vista entusiasmante e si vorrebbe essere lì a guardarlo quando avverrà, ma proprio a causa della sua vicinanza, è invece meglio augurarsi di non esserci, perché potrebbe avere ripercussioni sulla Terra, come l’estinzione di qualche specie…
Rigel: il nome deriva dall’arabo Rijl jawza al-yusra, che significa il piede sinistro di Colui che è Centrale.
Rigel è la settima stella più luminosa di tutta la volta celeste.
Johann Bayer la riconobbe come la stella beta della costellazione, ovvero la seconda più luminosa in Orione. Ma si sbagliò: sarebbe Rigel la vera alpha Orionis, quella che Bayer associò erroneamente a Betelgeuse. La sua magnitudine apparente infatti è 0,1 contro la 0,5 di Betelgeuse: dal momento che più alto è il valore della magnitudine e più debole è la luminosità della stella, ecco che Rigel è più brillante di Betelgeuse.
Risiede a circa 900 anni luce dal Sole e anche nel caso di Rigel, 900 anni non sono un intervallo di tempo significativo in termini evolutivi. Ricordiamo infatti che la distanza in tempo-luce di una stella equivale al tempo trascorso da quando i suoi raggi luminosi sono partiti dalla sua superficie. L’immagine che ci arriva oggi di Rigel è perciò quella di quasi mille anni fa, mentre la luce che parte in questo momento da Rigel, approderà sul nostro pianeta solo fra mille anni.
La magnitudine assoluta di questa stella è –6,7 contro la –5,6 di Betelgeuse. Se ne deduce quindi che, in termini assoluti, Rigel è meno luminosa di Betelgeuse. Rigel è perciò apparentemente più brillante di Betelgeuse e assolutamente più debole.
Come si giustificano questi risultati? La risposta sta nella sua “identità”: quando guardiamo Rigel, stiamo osservando una Supergigante Blu. Così Rigel è una Supergigante come Betelgeuse, tranne che per il suo colore.
In astronomia i colori delle stelle non sono attributi estetici, nonostante non manchino di regalarci emozioni, ma sono delle vere e proprie unità di misura, poiché essi ci danno sia una indicazione della temperatura che c’è sulla superficie della stella, sia un’idea della fase evolutiva che l’astro sta attraversando. Il blu e il rosso in particolare costituiscono le due estremità della gamma cromatica che possono assumere le stelle: quelle blu sono stelle molto calde e giovani, mentre quelle rosse sono al contrario stelle fredde e vecchie. La blu Rigel è allora una stella giovane e calda, la sua temperatura superficiale è di circa 11.000 °K, quasi il doppio di quella del nostro Sole e il quadruplo di quella di Betelgeuse.
E Rigel è stata definita Supergigante, una classificazione che ha a che fare con le dimensioni e/o con la massa della stella rispetto a quelle del Sole; mentre nel caso di Betelgeuse sono le dimensioni che la classificano come Supergigante, nel caso di Rigel è la sua massa, e di conseguenza luminosità, che la rendono tale: la sua massa è infatti ben 17 volte più grande di quella del nostro astro ed in cielo brilla quasi 40.000 volte di più del Sole! Anche se è principalmente la sua grande massa che le conferisce il titolo di Supergigante, va comunque rilevato che il suo diametro è considerevolmente maggiore di quello del Sole, superandolo grossomodo di 70 volte.
Tornando alla domanda iniziale, a prima vista suona sicuramente strano che una stella calda come Rigel, sia invece meno “potente” in termini di luminosità rispetto a Betelgeuse. In verità, questa circostanza si giustifica considerando che è vero che Rigel è molto più calda di Betelgeuse, ragion per cui si sarebbe portati a pensare che dovrebbe essere anche più luminosa, ma è anche vero che Betelgeuse ha un diametro 7 volte maggiore. Questo significa che, anche se ogni centimetro cubo di Betelgeuse emette un raggio di luce freddo, il numero di centimetri cubi della superficie è così elevato che il loro contributo totale dà una luminosità più alta. E questo è conseguentemente il motivo per cui Rigel ha una magnitudine assoluta minore di quella di Betelgeuse.
Oggetti famosi nelle costellazioni di Dicembre
In orione
La Nebulosa M42
|
Volgete il vostro sguardo verso la stella theta di Orione: state guardando la parte centrale di quella che viene chiamata “la spada” della costellazione. Se questa spada fosse vera, essa avrebbe un valore inestimabile. Nel centro della lama infatti, vi è impresso un sigillo estremamente prezioso: è la Nebulosa di Orione (Fig. 6). Questo sottile velo diffuso è visibile anche ad occhio nudo in un cielo terso, grazie alla sua magnitudine apparente di 3.0, che rientra fra quelle ancora osservabili senza l’aiuto di uno strumento.
Si tratta di un’ampia distesa di idrogeno ionizzato e polvere interstellare, immersa in uno spazio lontano 1.600 anni luce. Impiegheremmo 30 anni per attraversarla potendo viaggiare alla velocità della luce. E all’insegna di continui scossoni dovuti alla forte turbolenza, ci troveremmo a solcare un gigantesco territorio in movimento, con velocità diverse a seconda dell’area in cui ci troviamo rispetto al suo centro di gravità. Gli addensamenti gassosi più esterni si muovono mediamente a 10 km/s, ma quelli più interni raggiungono velocità anche 5 volte superiori per potersi mantenere in equilibrio gravitazionale. |
 fig.6 fig.6 |
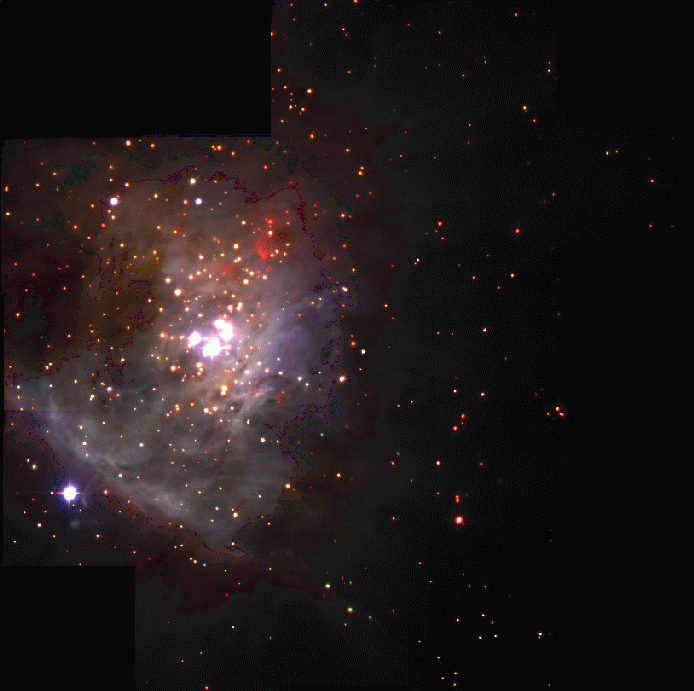 fig.7 fig.7 |
La nostra navigazione avverrebbe all’interno di una massa forse 300 volte quella del Sole e, nelle sue zone più interne, vedremmo la temperatura salire rapidamente a 10.000°K, mentre ai bordi un gelo mortale ci avvolgerebbe. Perché questa colossale nube è tanto preziosa? Ebbene, la risposta sta nella sua composizione chimica: tutto l’idrogeno ionizzato e le polveri interstellari di cui è disseminata, la rendono un vero e proprio campo fertile: se sulla Terra abbiamo i campi di grano, quando guardiamo la Nebulosa di Orione, beh siamo di fronte a un campo di stelle…
M42, l’altro nome della nebulosa secondo il catalogo di Messier, è il territorio nel quale nascono le stelle, un enorme grembo che molte ne ha già dato alla luce. Questa nebulosa fra l’altro è la regione di formazione stellare più vicina alla Terra.
La stella Theta Orionis a cui abbiamo rivolto lo sguardo, è in realtà un insieme di stelle molto giovani, circa un milione di anni, nato proprio da questo “terreno celeste”. Le giovanissime stelle sono molto vicine fra loro, distano infatti solo qualche settimana luce l’una dall’altra, e per questo sulle carte stellari vengono raggruppate sotto il nome di un’unica stella. |
|
Ma una mappa che mostri il dettaglio di questa zona di Orione, rivelerebbe appunto che la Theta Orionis non è una sola stella, ma è un giovane ammasso aperto chiamato Trapezio dalla disposizione delle sue quattro stelle più luminose(Fig. 7). E’ proprio grazie ad esso che la Nebulosa di Orione è visibile; protetto dal
prosperoso grembo materno infatti, esso la illumina e ci regala uno spettacolo che difficilmente sapremmo immaginare.
Le stelle del Trapezio, in quanto giovani di età e quindi molto calde (dai 25.000°K ai 50.000°K), emettono una intensa radiazione ultravioletta che, all’impatto con l’idrogeno presente nella nube, la ionizza e fa sì che essa a sua volta emetta radiazione nella parte visibile dello spettro elettromagnetico (Fig. 8). E’ quindi grazie a questo fenomeno, che i nostri occhi possono ammirarla. E sempre a causa di questo fenomeno, la Nebulosa di Orione è classificata come nebulosa ad emissione.
Le nebulose ad emissione si hanno quando contengono una o più stelle molto calde, la cui azione è quella di riscaldare il gas della nube, facendo sì che esso emetta a sua volta secondo i propri colori: gli atomi ionizzati dell’idrogeno nel rosso e i pochi dell’ossigeno nel verde. |
 fig.8 fig.8 |
Essendo l’idrogeno il componente principale, il colore predominante delle nebulose è il rosso. Attenzione però: se accostate il vostro occhio al telescopio, avreste una sorpresa… La Nebulosa vi apparirebbe verde! Come mai? Il motivo sta nella natura dell’occhio umano, che è sensibile alla radiazione dell’ossigeno (in questo caso ionizzato due volte, OII), il quale emette nella fascia verde dello spettro visibile. La vostra macchina fotografica invece vi darebbe un’immagine rossa della Nebulosa (Fig. 6), perché le pellicole sono più sensibili all’idrogeno. Per le nebulose ad emissione dunque, l’immagine più veritiera sarebbe quella fotografica, poiché vi è una coincidenza fra la sensibilità della pellicola fotografica e la prevalenza dell’idrogeno nel gas diffuso.
Ma M42 non è solo una nebulosa ad emissione. Essa è anche una nebulosa a riflessione. Questo tipo di nubi si ha quando all’interno sono presenti stelle “più fredde”, nel senso che la loro temperatura non è sufficientemente elevata da riuscire a ionizzare il gas circostante e indurlo così ad emettere a sua volta. Nella Nebulosa di Orione, vi sono regioni che contengono stelle di questo tipo. Esse stavolta mostrano i loro effetti non sull’idrogeno, ma sulla seconda componente più abbondante della nube: la polvere interstellare. Si tratta di granelli di materia solida dal diametro di un millesimo di millimetro che, su scala atomica, è una dimensione molto elevata. Facciamo notare però che la polvere è sì il secondo ingrediente più copioso nelle nebulose, ma si sappia che stiamo parlando di un rapporto in massa di 1 a 100 rispetto agli atomi di idrogeno.
Ebbene, le stelle che non sono in grado di ionizzare l’idrogeno, riflettono la loro luce sui grani di polvere, i quali hanno la proprietà di diffondere prevalentemente i raggi blu degli astri, lasciando intatti invece quelli rossi nella direzione in cui il loro spessore è maggiore. E infatti, l’effetto principale della polvere interstellare è quello di arrossare l’immagine di un oggetto celeste che vi stia dietro, e di emettere intensamente nell’infrarosso. Così ci appaiono perciò quelle zone di M42 in cui sono concentrate stelle molto giovani, meno di 100.000 anni, non ancora sufficientemente calde per emettere luce visibile.
La nebulosa di Orione è un gioiello astronomico tenuto pressoché sotto costante osservazione, perché come abbiamo visto, ci svela i segreti della genesi delle stelle. Ma tutto questo non sarebbe sufficiente per decretare M42 a “fucina di stelle”, se non si aggiungesse un’altra sua prerogativa fondamentale: molte delle stelle in essa nascenti sono circondate da un disco di polveri e gas che in futuro darà vita a dei pianeti! E pianeti significa possibilità di vita…
Sono stati osservati più di 150 dischi protoplanetari attorno alla maggior parte delle stelle appena nate. Ispezionandoli nell’infrarosso, si è visto che i grani di polvere ivi residenti, si stanno ingrandendo: sono i futuri pianeti. Diventeranno tali quando la protostella che li riscalda diventerà una vera e propria stella. Al momento si chiamano planetesimi e ruotano attorno alla loro nutrice come in una religiosa processione…
Tutte queste cose è la Nebulosa di Orione, un incontenibile e incessante inno alla vita che raggiunge il nostro pianeta abbandonato nell’infinito silenzio cosmico.
La Nebulosa Testa di Cavallo
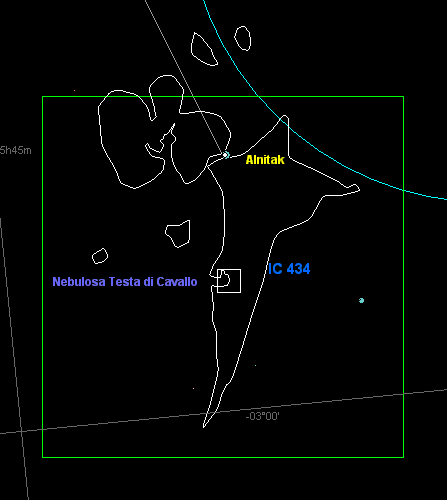 fig.9 fig.9 |
Se, come abbiamo visto, Orione ha una spada estremamente preziosa, non è da meno la sua cintura. Non tanto per fenomeni astrofisici importanti come quelli che stanno accadendo in M42, quanto per una bizzarra fatalità che non ha mai smesso di affascinare tutte le generazioni di appassionati e non; un capriccio estetico
che ha trasformato questa parte di cielo in un’immagine così famosa, che in campo astronomico potrebbe competere con la Gioconda di Leonardo: stiamo parlando della Testa di Cavallo nella costellazione di Orione.
Magari la gente comune non sa che si trova in Orione, ma di sicuro sottoponendole la foto esclamerebbe: “Ma certo! E’ la Testa di Cavallo!”. Oppure: “Ah sì… è la Testa di Cavallo. E allora?”. Bene, mi saprebbe dire anche in quale costellazione si trova? Ecco, qui il 90% delle volte occorre rassegnarsi alla speranza di una risposta…Con entrambi gli intervistati.
Un’altra delle cose buffe di questa, consentitemi il termine, leggenda scientifica, è che la notorietà di questa foto ha fatto sì che nell’immaginario collettivo, si sia impressa la convinzione che la Testa di Cavallo sia un oggetto facile da osservare, una volta accostato l’occhio al telescopio: non è così. Questa nebulosa infatti non è che una piccolissima parte di una nebulosa 100 volte più grande, ma il cui nome è sconosciuto ai più, così come la sua stessa esistenza. In particolare la Testa di Cavallo ha un’estensione di 6’ x 4’ . Il nostro telescopio quindi deve focalizzare un’area piuttosto ridotta della volta celeste, e questo richiede un po’ di pazienza. Inoltre, come vedremo, la Testa di Cavallo è una nebulosa oscura cioè, come dice la parola stessa, non è luminosa, attributo che complica ulteriormente la sua localizzazione.
Un osservatore esperto se la caverebbe senz’altro bene, ma l’individuazione richiederebbe anche a lui un certo tempo. |
|
Infine, un’altra consuetudine da correggere riguarda il suo orientamento: se finalmente riuscite a guardare la Testa di Cavallo al telescopio, vi accorgereste che, rispetto a quanto pubblicato, è inclinata di 90 gradi (Fig. 9).
Fatte le dovute premesse, sì: là all’estremo sud della cintura di Orione, poco sotto Alnitak, la Zeta Orionis, un cavallo nero si staglia imbizzarrito su un cielo rosso, apocalittico, come travolto da un mare ingrossato (Fig. 10). L’immagine è davvero spettacolare e viene spontaneo chiedersi se è vero o è un sogno. In una zona di cielo distante 1.600 anni luce da noi, c’è un cavallo che sfida le profondità del cosmo, che ci volge le spalle e impetuoso non smette la sua corsa in avanti.
Ma cos’è scientificamente la Testa di Cavallo in Orione? In verità, si tratta di una nebulosa, un tipo nuovo di nebulosa rispetto a M42 che ci ha fatto conoscere le nebulose ad emissione e a riflessione.
Qui invece siamo di fronte ad una nebulosa oscura ossia ad una distesa di gas e polveri che al proprio interno non contiene nessuna stella che possa illuminarla. Essa vive della luce riflessa dal resto della, IC 434, la quale agisce appunto come uno sfondo luminoso che traccia la sagoma della nube scura. A sua volta IC 434 è illuminata dalle stelle Alnitak e Sigma Orionis. |
 fig.10 fig.10 |
 fig.11 fig.11 |
Fisicamente, la Testa di Cavallo consiste di uno strato molto spesso di polvere che assorbe completamente i raggi provenienti dalle stelle che vi stanno dietro. Questa luce è quindi bloccata e ciò che resta è la massa buia che casualmente assomiglia alla testa di un cavallo. L’ampiezza della nebulosa oscura è di circa 3,5 anni luce.
Le immagini più recenti e più dettagliate della nebulosa, mostrano però la presenza di alcuni sottili filamenti rossi (Fig. 11). Si può notare infatti che lì il gas è più rarefatto e la radiazione proveniente dalla Sigma Orionis è pertanto in grado di ionizzarlo. Guardando bene, si vedono anche dei puntini chiari sparsi qua e là nella nube oscura (Fig. 11): si tratta di stelle nascenti. E chissà, forse un giorno proprio loro accendendosi, trasformeranno la nebulosa Testa di Cavallo in una nebulosa ad emissione o a riflessione, e cancelleranno per sempre quella somiglianza che tanto ci ha incantato. Il cavallo nero terminerà allora la sua corsa e si dissolverà silenzioso nell’infinito. Ma per questo fortunatamente c’è tempo, tanto tempo… |
Ilaria Sganzerla
Riferimenti bibliografici:
- Collins Gem Guide, The Night Sky
- Mario Cavedon, Astronomia
- Hubert Reeves, L’Evoluzione Cosmica
- Yale Bright Star Catalogue, 4th edition
- John Gribbin, Companion to the Cosmos
- La Biblioteca di Repubblica, collana "La scienza", 1 L'Universo
- Ian Ridpath, The Pocket Guide To Astronomy
- Isaac Asimov, Supernovae
- Wikipedia
Mappe generate con "Cartes du Ciel"
Fonte internet:
- Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Aries_(constellation)
- Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Lepus_(constellation)
- Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Columba_(constellation)
Immagini provenienti da: http://hubblesite.org, www.eso.org
|
|
 fig.2
fig.2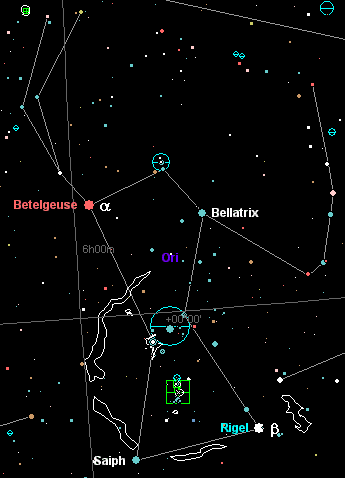 fig.1
fig.1 fig.3
fig.3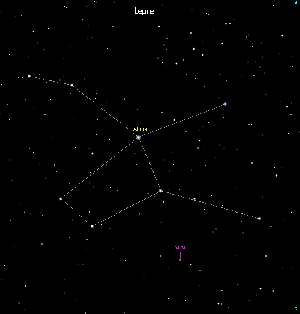 fig.1l
fig.1l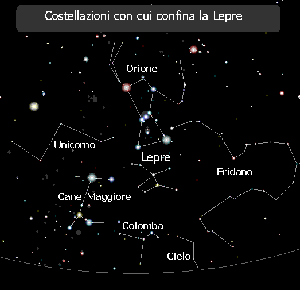 fig.2l
fig.2l fig.3l
fig.3l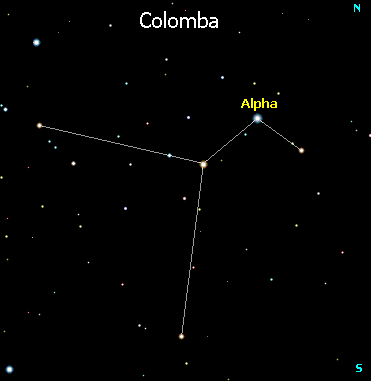 fig.5c
fig.5c fig.6c
fig.6c fig.6
fig.6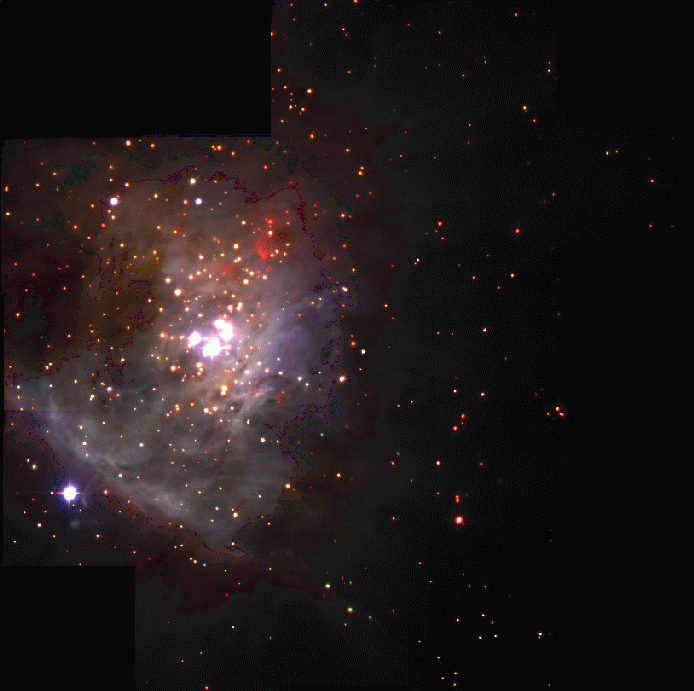 fig.7
fig.7 fig.8
fig.8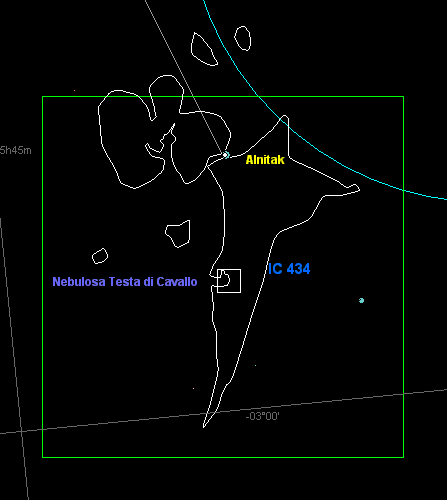 fig.9
fig.9 fig.10
fig.10 fig.11
fig.11